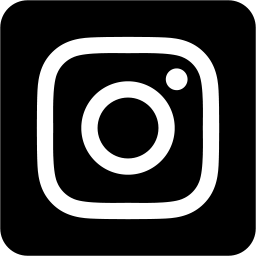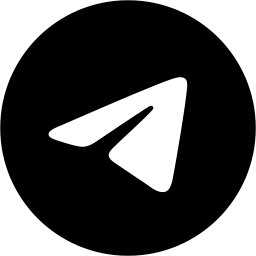La storia dei Supertuscan, la storia tra giovinezza e maturità.
Dalla Toscana a tutta l'Italia
I Supertuscan (o super tuscan) erano già affermati nel 1996, quando Angelo Gaja, monumentale viticoltore piemontese, decise di acquistare un vigneto nella Maremma Toscana: Ca’ Marcanda. Quell’operazione, prima ancora di essere un investimento, era la conferma del consolidamento di una tendenza che vedeva nei vitigni internazionali, quali Merlot o Cabernet, una grande prospettiva di espansione commerciale all’estero.
Gli anni 90, in Toscana, videro i Supertuscan rubare la scena ai vini toscani più tipici come il Chianti Classico oppure il Brunello di Montalcino. In quella decade non si faceva altro che parlare di questi vini speciali, di taglio bordolese e di barrique, a corredo di un successo commerciale sotto gli occhi di tutti gli operatori di settore e appassionati.
Era il “nuovo che avanza”, senza regole e senza sponsor, vini ribelli, senza regolamentazione, commercializzati semplicemente come “Vino da Tavola”, a differenza dei DOC o DOCG che godevano di certificazioni istituzionali. La tensione tra i produttori tradizionali e i nuovi arrivati era molta, si ricorda a titolo d’esempio lo scandalo del Brunello di Montalcino, dove alcuni produttori tagliarono il Sangiovese con varietà di uve non permesse dal disciplinare, per ottenere aromi più vicini ai nuovi gusti dettati dal movimento Supertuscan. La pressione dei produttori Toscani sulle istituzioni era molta, si chiedeva, ad esempio, di poter coltivare Cabernet Franc, Merlot ed altri vitigni internazionali ed essere liberi di mischiarlo con il tradizionale Sangiovese (ceppo autoctono toscano) per ottenere nuovi assemblaggi che rispondessero alle esigenze di mercato.
Ma dove ebbe inizio tutto?
Per quale ragione si arrivò a preferire vitigni internazionali in Toscana?
Cosa avevano questi vitigni rispetto ai più tipici e tradizionali?
I vini risultati dall’utilizzo delle uve di vitigni internazionali erano molto differenti. Agli occhi, al naso e al palato dei consumatori, i vini Toscani tipici avevano un colore tenue con un’acidità fruttata e nulla potevano contro le bombe di frutta matura e scura, dal corpo pieno e con sentori di vaniglia dei Supertuscan. Il mercato voleva quei colori e quel sapore, in particolare il mercato americano e, come in Piemonte dove il Barolo affinato in botte piccola stava facendo discutere molti produttori (Barolo Boys), anche in Toscana molti produttori decisero di favorire i vitigni internazionali rispetto a quelli tipici. Si sacrificò una parte di storia in favore di una tendenza dettata dal mercato.
Gli anni 2000 in Toscana
Le tendenze prima e le mode poi, sono destinate a mutare, ed anche nella Toscana del vino le cose iniziarono a cambiare, e lo stesso mercato ritracciò verso un’autenticità che in parte era stata persa. Si tornò a parlare di territorio, di tipicità e di autenticità. Gli anni 2000 videro meno eccessi negli assemblaggi e nei passaggi in legno, videro meno esaltazione della parte “super” di questi vini in favore di freschezza, finezza ed eleganza. Ma questo non significava che il fenomeno dei Supertuscan fosse finito. Axel Heinz, enologo di Tenuta dell’Ornellaia, dichiarò che nonostante tutto, il termine “Supertuscan” era ancora molto importante per i mercati internazionali. Quindi non se ne poteva fare a meno, in un modo o nell’altro era necessario trovare un equilibrio con il territorio.
Quale è stato il primo Supertuscan della storia?
Il primo supertuscan della storia è stato il Vigorello. I Supertuscans nacquero con Sassicaia in maremma e con Vigorello a Siena, ma passarono alcuni anni prima che questi potessero raggiungere la diffusione e lo splendore che oggi conosciamo. Inizialmente erano degli esperimenti fatti da uomini visionari utilizzando uve di qualità ma senza una vera e propria identità.
Nel 1988, Sassicaia trionfava sui mercati per critica e vendite, dopo 10 anni dalla prima bottiglia le cose era cambiate radicalmente, Sassicaia era già nella leggenda. Con Sassicaia salirono sul carro dei vincenti molte altre etichette ancora oggi in vetta alle classifiche oltre che i listini prezzi. Utilizzando varietà internazionali, la Toscana scalò rapidamente il successo nei mercati che conoscevano e apprezzavano questo tipo di vino.
Sempre in Italia ma in Piemonte, invece, si continuò a lavorare con le varietà coltivate da sempre come Nebbiolo, Barbera, Dolcetto.
In Toscana, grazie alla spinta dei mercati, si continuò a piantare nuovi cloni, così da avere maggiore densità di impianto e in cantina si sostituirono i fusti di legno utilizzati con nuovi serbatoi di acciaio inossidabile e controllo della temperatura di fermentazione, il massimo dell’igiene. Naturalmente non poteva mancare l’ingrediente principale dei nuovi vini: la piccola barrique di provenienza francese, in grado di donare quei sentori di legno e di vaniglia che tanto piacciono agli americani.
I Supertuscan, come è facile intuire, furono fin dall'inizio un miscuglio di vari stili, che avevano solo una cosa in comune: erano costosi, non rientravano in nessuna delle denominazioni di origine esistenti (DOC, DOCG) ed erano venduti come “Vino da Tavola” poiché nessuna denominazione poteva accogliere la loro miscela.
Tra i vitigni preferiti per la composizione di un Supertuscan non c'erano solo varietà internazionali come il Cabernet Sauvignon e Merlot, ma anche l'autoctono toscano Sangiovese, a condizione che fosse elaborato in varietale come ad esempio nel Chianti, dove Tignanello spopolava. Anche Giovanni Manetti di Fontodi o Paolo de Marchi, di Isole e Olena, dovettero imbottigliare come vino da tavola Flaccianello della Pieve e Cepparello. Stessa sorte per il leggendario Le Pergole Torte di Montevertine, un Sangiovese in purezza voluto da Sergio Manetti.
Ma a differenza della DOCG, il nome non ufficiale di "Supertuscan" conteneva quasi tutto: sia l'elegante finezza e lo stile bordeaux del Sassicaia, come l'opulenza massiccia del Masseto o il fruttato robusto del Sangiovese in un Cepparello, tre stili che presto trovarono imitatori in tutta la regione.
Tornando a Sassicaia, uno dei primi Supertuscan e sicuramente tra i più influenti del movimento, il creatore, Mario Incisa della Rocchetta voleva realizzare un vino che rispondesse alla sua predilezione per certi vini francesi, non a caso le prime barbatelle impiantate provenivano dalla Francia. Le uve per il Sassicaia continuano a crescere e maturare anche oggi negli stessi luoghi di una volta, ed anche lo stile del vino è lo stesso. Il Marchese Nicolò Incisa della Rocchetta, figlio di Mario e attuale proprietario della Tenuta San Guido, considera il Sassicaia un vino senza tempo, ma non per questo uno vino vecchio: "Abbiamo sempre utilizzato uve degli stessi tre o quattro vigneti, non ne abbiamo mai aggiunti di nuovi, abbiamo solo ampliato quelli esistenti". Così, la composizione di base del vino è rimasta la stessa: molto Cabernet Sauvignon e poco Cabernet Franc.
Le prime annate di Sassicaia sono state distribuite dai cugini della famiglia Incisa della Rocchetta: i Marchesi Antinori di Firenze, da secoli grandi figure dell'enologia italiana.
Anche al marchese Piero Antinori piaceva l'idea di un vino toscano nuovo e diverso, ma non scelse la costa Toscana come zona di sperimentazione, bensì iniziò a produrre la propria interpretazione in una serie di vigneti della Val di Pesa, nei colli fiorentini. Qui vide la luce Tignanello come vino Supertuscan, in cui la varietà autoctona Sangiovese doveva costituire la percentuale più alta.
L'annata 1971 vide la luce il primo Tignanello non dichiarato come Chianti Classico per via delle scelte fatte nell’assemblaggio. Quella del 1975 fu elaborata senza varietà bianche, il Sangiovese era stato migliorato con un 20% di Cabernet Sauvignon e con un passaggio in barrique.
Ancor di più del Sassicaia, che in realtà proveniva da una zona ancora poco conosciuta per la sua vinificazione, fu Tignanello a stupire, direttamente dai colli fiorentini.
Qualcosa di simile aveva già provato la Tenuta San Felice con il Vigorello, ma con un successo minore, poiché forse, la forza commerciale era inferiore a quella di Antinori, ancora oggi un colosso dell’enologia italiana.
Oltre ad una macchina del marketing perfettamente calibrata, anche i viticoltori svolsero un ruolo importante nella scena Supertuscan, nelle scelte fatte in vigna ed in cantina. In Toscana arrivarono molte figure di spicco della cultura enoica francese. ricordiamo Michel Rolland, che raggiunse la Toscana attraverso la partecipazione di Robert Mondavi in Tenute dell’Ornellaia, ed è ancora oggi attivo in Monteverro.
Il fenomeno Supertuscan era spinto dalla stampa specialistica italiana ed internazionale: Gambero Rosso o le americane Wine Spectator e Wine Advocate. Maurizio Castelli, Franco Bernabei, Vittorio Fiore, Attiglio Pagli e, naturalmente Carlo Ferrini, mutarono da esperti di vini a vignaioli famosi, quasi delle rockstar. Nel mondo del vino non si chiedeva più l'origine, ma l'enologo dietro la bottiglia, nuove superstar per gli appassionati di vino.
La conseguenza fu che enologi come Carlo Ferrini o Riccardo Cotarella dall'Umbria crearono molti dei vini più premiati d'Italia. Il loro coinvolgimento era praticamente una garanzia per il raggiungimento dei famosi tre bicchieri di Gambero Rosso. Tra questi tecnici va menzionato con particolare rilievo Giacomo Tachis, una delle più grandi oltre che influenti figure italiane legate al mondo dei Supertuscan. A Giacomo Tachis si devono alcuni dei più famosi Supertuscan come Sassicaia, Solaia e Tignanello; e non sono i soli.
Gli ingredienti di questi vini erano sempre gli stessi: frutta scura, matura e legno. Ben presto queste super sensazioni non furono più prodotte solo in Toscana, ma cominciarono a prodursi sia nel sud del Tirolo che in Sicilia, tuttavia, la parola supertuscan è stata riservata solo a quelli prodotti in Toscana.
Supertuscan vini pregiati da investimento
Essendo la ricetta semplice, ma costosa, attirò in Toscana sempre più facoltosi investitori dei settori più diversi: Zar della moda come Cavalli o Ferragamo investirono in una tenuta, così come il cantante Sting (Il Palagio) e altri personaggi famosi. Vittorio Moretti, costruttore e proprietario della cantina Bellavista in Franciacorta, non si lasciò sfuggire l’opportunità con la meravigliosa azienda vinicola Petra, costruita a Suvereto con una struttura architettonica che lascia senza parole.

I Supertuscan evolvevano continuamente e ben presto arrivarono sul mercato vini con il 15% o più di alcool dove nelle degustazioni impressionavano con la loro pienezza e densità.
L'archetipo di questo stile di Supertuscan era il Masseto, creato a metà degli anni ottanta da Lodovico Antinori (vedi anche Tenuta Biserno), in Bolgheri: consistente, maestoso ed elegante, oggetto di opinioni contrastanti: alcuni lo adorano, altri lo detestano. Masseto non era un vino assemblato in cantina, ma il risultato di una singola vigna. Masseto è stato fatto nello stesso modo dai primi anni 90.
Per molto tempo il Masseto è stato il Supertuscan per eccellenza, ancor più di Sassicaia o Tignanello. E fu proprio il successo di Masseto che motivò le innumerevoli emulazioni che arrivarono sul mercato, soprattutto sulla costa toscana. Queste erano vini esagerati, quasi delle caricature dell’idea iniziale, con il solo scopo di impressionare per potenza ed aromi utilizzando ogni tecnica nota per raggiungere il risultato, spesso erano utilizzate uve vicine all’appassimento.
Di questi vini nessuno sente più la mancanza, anche perché negli anni 2000 tutto cambiò: Quasi una seconda primavera enologica italiana in cui molte delle botti piccole furono sostituite con quelle grandi.
Le varietà di uve internazionali cominciarono a cedere il passo a quelle autoctone, il mercato non apprezzava più le vette alcoliche viste in precedenza, ma chiedeva finezza ed eleganza. L'Italia, sempre così attenta alla moda, virò da un estremo all'altro in men che non si dica, per seguire la nuova tendenza.
La rinascita degli autoctoni sugli internazionali
Nella costa toscana si producevano principalmente Supertuscan con vitigni quali Cabernet, Merlot, Syrah, Alicante e ceppi anche più esotici, sempre potenti, sempre densi, sempre affinati in barrique.
La costa toscana era stata considerata la miniera d'oro di tutta la Toscana enologica e moltissimi produttori fuori regione investirono in vigne e possedimenti di questa zona, dove le brezze del Mar Tirreno donavano sollievo alle viti durante la notte. Furono impiantati innumerevoli ettari di vigneto, anche in zone che non avevano mai visto prima un solo grappolo d’uva.
Tuttavia, le cose stavano per cambiare. I vini a base di vitigni internazionali iniziarono a ridurre le proprie quote di mercato, questo portò ad una sorta di crisi, particolarmente sentita in Maremma.
Anche le guide enologiche italiane, che per molti anni erano state i profeti delle nuove regioni vinicole e dei loro vini, già dalla metà del nuovo decennio iniziarono a preferire e stimolare i consumatori con i vitigni autoctoni più tipici. Si stima che la domanda diminuì diminuita di un terzo.
A Bolgheri cercarono di risolvere il problema: il numero di ettari consentito per piantare vigneti fu limitato in appena mille, e non era possibile piantare nuovi vigneti.
“L'essenziale è riuscire a vendere quello che già produciamo”, spiega Nicolò Incisa della Rocchetta, presidente del Consorzio Produttori Bolgheri DOC. Bolgheri, dopo tutto, è la regione più favorita della costa: produttori come Tenuta San Guido e Tenuta dell’Ornellaia non sentirono direttamente la flessione del mercato, grazie a marchi molto affermati e conosciuti. Le cose furono differenti per i piccoli vignaioli, quelli che erano ancora riusciti ad affermare la propria etichetta e che per questo motivo subirono di più la crisi.
Si cominciò quindi a cercare di riparare all’errore commesso, se così si può dire, innestando le piante di Cabernet con Sangiovese, come successe nel Chianti, dove si valorizzò anche il Cannaiolo. Il Merlot fu permesso in parte minore dal disciplinare del Chianti. Il recupero con Innesto non fu possibile in Maremma, dove non vi erano terreni adatti al Sangiovese se non in minoranza.
Per salvaguardare il grande capitale di vigne, anche di vitigni internazionali molte delle denominazioni d'origine create negli ultimi 10 anni furono modificati per accogliere varietà internazionali, anche quelle meno diffuse. Ma il passaggio da “Vino da Tavola” a vino con certificazione fu grazie alla denominazione Toscana IGT, la più scelta dai Supertuscan, e così è ancora oggi, una delle denominazioni più libere di tutta la Toscana.
Vini supertuscan a prezzi di saldo?
L'antico splendore dei Supertuscan, anche in termini di prezzo, stava perdendo smalto e non furono pochi i marchi che entrarono nel circuito delle GDO, come lo stesso Tignanello, ancora oggi venduto nei supermercati. Inizialmente l’ingresso nei supermercati fu qualcosa di nuovo e rivoluzionario, oggi, ha un sapore differente, poichè è possibile trovare anche vini molto costosi e pregiati.
I prezzi ridotti stimolarono nuovamente il mercato e molti consumatori tornarono ad acquistare Supertuscan, anche chi era al suo primo acquisto. Supertuscan rappresentava un’idea di qualche decennio prima, negli anni 80 in cui si cercava un’esplosione di frutta matura, tannino e legno. Rappresenta una parte del percorso enologico italiano a cui non si può voltare le spalle e grazie al quale sono state create nuove rotte, commerciali e colturali. Alcuni dei marchi creati in quel periodo, sarebbero in grado di continuare a vendere anche senza il termine Supertuscan, associato al loro nome.
Chi ha inventato i Supertuscan?
Secondo la leggenda, il termine Supertuscan è stato inventato dalla critica enologica americana, anche se ci sono altre teorie che fanno riferimento ad un commerciante di vini inglese. Il famoso critico americano Robert Parker, avvocato di professione, con la sua rivista Wine Advocate, è stato decisivo per l'ascesa al successo dei vini Supertuscan, infatti nelle sue pagine egli rese evidente a tutto il mondo che i nuovi vini toscani rispondevano allo stile di vino da lui preferito: maturo e fruttato, ricco di tannini, pieno e affinato in barrique.
Per Parker, le DOC e DOCG tipiche italiane non potevano competere con questi nuovi vini: Brunello di Montalcino e Chianti Classico, ma anche Barolo e Barbaresco in Piemonte, erano solo sinonimo di eleganza e longevità, inoltre ricoperti da uno strato di polvere “aristorurale”. Vini antichi e bigotti rispetto ai vini emergenti del Nuovo Mondo, che aveva la California in testa.
Il mercato statunitense fu subito entusiasta di questa nuovi vini, una sola parola riassumeva tutto: Supertuscan, i vini più magnifici della Toscana, come il Superbowl o la Super League, o il Super Nintendo e le superstar.


Elenco parziale dei vini Supertuscan
I vini che rientrano nella definizione Supertuscan sono molti, forse troppi da elencare in quello che potrebbe essere una lista dei Supertuscan. Non è semplice stilare un elenco per via della grazie quantità di vini super tuscan presenti nel mercato. I più noti, dai prezzi stellari, sono ormai conosciuti da ogni appassionato di super tuscan, vini entrati nella leggenda.
Guado al Tasso galleria fotografica e presentazione dei vini
Galleria fotografica di Guado al Tasso, colline, vigneti e vini nel cuore di Bolgheri
Tenuta Tignanello galleria fotografica e presentazione dei vini
Galleria fotografica di Tenuta Tignanello, colline, vigneti e vini nel cuore del Chianti Classico
Sassicaia 2018 disponibile per l'acquisto
Il 12 marzo 2021 Sassicaia 2018 è disponibile realmente in alcuni shop selezionati. Disponibilità limitate.