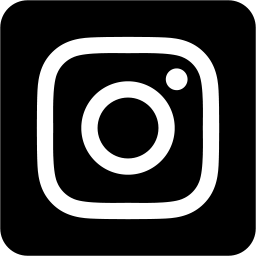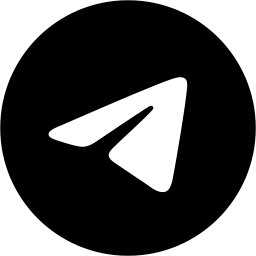Ronchi di Cialla: storia e degustazione presentati da Enobucolico

Enobucolico
Grande appassionato di vino
Ronchi di Cialla: Il luogo della rinascita dello Schioppettino
Cinque anni fa, una bottiglia di Schioppettino. Così inizia la mia storia di oggi. Lavoravo all’epoca in un famoso, esclusivo ristorante di Londra, ora chiuso, tristemente.
Ricordo che vendevamo uno Schioppettino del 1999 (all’epoca un vino già quasi diciottenne), allo stesso prezzo di un Leoville Poyferre. Dunque caro. Circa 200 cartelle. Inusuale, secondo il me stesso di allora, sia per il prezzo che per la veneranda età. Da buon Veneto conoscevo lo Schioppettino come un vino da tavola abbastanza diffuso nelle osterie di Treviso e Venezia. Poi ho conosciuto lo Schioppettino di Cialla, nella sua più autorevole incarnazione, quella di Ronchi di Cialla. Ed ho capito tutto
Decido dunque di visitare la cantina nei Colli Orientali Friulani, grazie al supporto del mio Head Sommelier di allora. Metto il navigatore, parto. Dopo poco più di un’ora di strada il navigatore mi dice “sei arrivato a destinazione”. Tutto molto bello, se non fosse che mi trovavo in una stradina di campagna totalmente circondata dal nulla cosmico: non una casa in vista. Proseguo a tentoni, quasi come guidato dall’odore dell’uva mostata, e al primo “incrocio” seguo una stradina che sembra condurre all’unica abitazione della zona. Il fiuto ha funzionato, siamo arrivati a Ronchi di Cialla. La casa coloniale sorge in cima ad una piccola collina, in una posizione di comando sulla stretta valle sottostante. Il panorama bucolico che si offre ai miei occhi è totalmente dominato dalla natura: alberi e viti sono re e regine. Da notare che Cialla è il nome di questo Cru, per dirla alla francese, mentre Ronchi di Cialla è l’unica cantina a produrvi vino.
Veniamo accolti dai proprietari, la famiglia Rapuzzi, che ci invita direttamente nel loro salotto di casa per fare quattro chiacchiere. La famiglia Rapuzzi fonda Ronchi di Cialla nel 1970, rilevando una proprietà in disuso. Sono anni difficili in Friuli, la gente lascia le campagne per trasferirsi in città ed il vino non è ancora questione di moda ma di sostentamento.
Presto si accorgono della presenza di alcuni vecchi ceppi di circa 60 anni, che sembrano risalire ad una varietà pre-fillossera, ritenuta estinta. È una varietà storicamente legata a questa zona, documentata sin dal medioevo, ma che dall’ultimo dopoguerra era stata abbandonata e disconosciuta, a favore delle più produttive varietà internazionali. Appunto, lo Schioppettino.
Così per caso inizia il percorso di Ronchi di Cialla, che diventa ben presto una battaglia. Secondo il disciplinare di allora infatti, lo Schioppettino non è una varietà permessa, pertanto non è possibile commercializzare del vino proveniente da quest’uva, finita nell’oblio. Si chiama Schioppettino di Cialla, ma non si può fare a Cialla. Pazzesco. Tuttavia si sa, noi popoli italici abbiamo un rapporto speciale con le leggi, a buon diritto. L’azienda continua a coltivare lo Schioppettino, e ad imbottigliare il suo nettare fermentato: è buono, è davvero molto buono. La parola si sparge, tutti lo vogliono bere, e della legge assurda francamente, non sembra fregare niente agli avventori di Cialla. Le pressioni dell’azienda sul governo di Roma durano per alcuni anni, si aggiungono alcuni giornalisti a sostegno della causa, tra cui anche il compianto Veronelli. La battaglia verrà poi vinta: il 1977 è la prima annata a venir etichettata. Quasi 20 anni dopo, nel 1995, viene riconosciuta la microscopica subappellazione Cialla DOC.
Il successo non tarda ad arrivare. Presto i vini di Cialla iniziano a viaggiare, e lo Schioppettino si fa apprezzare ad alcuni degli eventi vinicoli più blasonati al mondo, dove viene accostato ai giganti dell’enologia. Tuttavia l’azienda non perde la sua identità, intrinsecamente bucolica, e sceglie di non indulgere nel proprio successo. Al grande favore della critica non corrisponde un ingiustificato e vertiginoso aumento nella produzione, o nel prezzo, come quasi sempre accade. Anzi, la famiglia Rapuzzi continua la propria strada, perpetuando la propria ricetta fatta di semplicità e dedizione. Tutt’oggi è rimasto così, a Ronchi di Cialla si ha la sensazione di trovarsi in casa di una comune famiglia friulana, dove ci si siede a tavola per fare conoscenza, mentre si mangia qualche fetta di salame e formaggio tagliata al momento. È proprio così il mondo che vorrei. Niente brochure, niente tappeti rossi e vetrate scintillanti, niente pacchetti premium. Pane, salame, vino, il trittico della felicità.
Ma non solo di Schioppettino si occupano a Ronchi di Cialla: vengono infatti coltivate altre varietà autoctone come il Refosco dal Peduncolo Rosso, il Verduzzo, la Ribolla, ed il leggendario Picolit. Cinque uve friulane, fortemente legate a questi colli. Identità e territorio. Da alcuni anni l’azienda è certificata Biodiversity Friend, un’associazione che promuove la biodiversità tramite un sistema di agricoltura sostenibile, a basso impatto ambientale. Ed in effetti a Cialla c’è molto da preservare, oltre alla vite, in quanto ci troviamo in una vera oasi naturale, a buona distanza da insediamenti umani, circondati da boschi incantati.
La produzione si divide tra i vini da lungo (lunghissimo) affinamento e i vini di pronta beva, dove i primi sono per lo più affinati in legno ed i secondi in acciaio. Piccola curiosità: pare che il Ciallabianco sia stato il primo bianco ad essere elevato in barrique in Italia, nei lontani anni 70. Oggi sul mercato troviamo il Ciallabianco 2017, e lo Schioppettino 2015. A Cialla non sembrano aver fretta di vendere i loro vini migliori, che anziché escono sul mercato già pronti, sia per essere bevuti, che per affrontare un ulteriore affinamento nelle cantine di qualche fortunato. E per chi ha meno pazienza, o semplicemente vuole sondare il potenziale di invecchiamento di questi vini, l’azienda ha disponibile un’importante libreria di vecchie annate.
Tra i vini della linea più “giovane”, se così possiamo chiamarla, spicca sicuramente la Ribolla Nera, che è il nome ufficioso dello Schioppettino. In questo vino spogliato dal legno, si può apprezzare la nota fresca pungente e pepata tipica di questo vitigno ricco di rotundone, il terpene che caratterizza l’aroma del pepe nero. Anche il Refosco Rosato è da tenere sott’occhio, un Rosè fresco ma di grande carattere ad un prezzo molto concorrenziale.
Nella batteria dei “fratelli maggiori” la musica cambia, entra in gioco l’influenza del rovere ed il segno del tempo trascorso a riposare ed evolvere.
Il Ciallabianco, prodotto dalla fusione delle 3 varietà a bacca bianca presenti nell’azienda, è un vino di ampio respiro, a tratti camaleontico, enigmatico. Ribolla, Verduzzo e Picolit sono uve piuttosto diverse tra loro, il cui prodotto è un mix di esuberanza, imponenza e un pizzico di sana ruffianeria. Nelle annate recenti il legno è ravvisabile, anche se a mio avviso non copre mai la delicata sinfonia floreale e fruttata dell’uva. Con il passare degli anni si accentua la voluttuosità di questo vino, con note di miele e noce moscata, fiori appassiti e agrumi caramellati. Ho provato di recente il 1998, un bianco di estrema eleganza, evoluto ma con acidità ancora ottima, che ne avrebbe consentito almeno altri dieci anni di affinamento.
Lo stesso principio vale per lo Schioppettino di Cialla a cui faccio menzione sopra, il 1999 è un vino che gioca su aromi terziari, di pellame, tè nero, ma che continua a reggersi su una spalla acida solida e sulla frutta ancora pungente. Essendo un vino pensato per durare a lungo, credo sia fondamentale aprirlo ad almeno dieci anni dalla vendemmia per poterne apprezzare il sottile equilibrio. È un rosso che sebbene venga classificato come “di struttura”, non possiede l’esuberante prepotenza delle uve bordolesi, e rimane sempre su un corpo medio, estremamente bilanciato. A maturità raggiunta sembra sussurrare pacatamente, poco a poco, la sua complessa essenza, senza mai esporsi in modo eccessivo.
Ultimo ma non meno importante, va menzionato il Sôl, un vino clamoroso che però viene prodotto solo 2 o 3 volte per decennio. Sôl è un Picolit in purezza, secco, fermentato ed affinato in barrique. Proviene da un vigneto di appena 1 ettaro, e ne vengono prodotte poche centinaia di bottiglie, nei pochi anni in cui viene prodotto. È un vino molto difficile da descrivere, dall’’aroma voluttuoso, opulento, tipico dei vini dolci; al naso si avverte il sentore del miele e dei fiori bianchi, che si lega alle spezie dolci e all’albicocca matura. In bocca però è asciutto, con acidità eccellente, di corpo pieno. L’unico esemplare che ho avuto la fortuna di provare è stato un 2009 che mi ha lasciato senza parole. Il prezzo è elevato, ma neanche troppo se si pensa alla scarsissima disponibilità ed all’unicità, che lo rendono de facto un vino-unicorno.



Enobucolico racconta e degusta i vini Pinot Bianco e Pinot Grigio
Ecco la storia dei due pinot e delle regioni che hanno saputo ospitare al meglio queste varietà: Alto Adige e Friuli.
Ettore Germano: viaggio in Serralunga d'Alba con Enobucolico
Un viaggio verso i vigneti delle Langhe. Enobucolico racconta la passione, la tradizione e l'evoluzione dei vini Ettore Germano
Lis Neris: nella valle dell'Isonzo con Enobucolico
Lis Neris, storia e degustazione dei vini: "Picol, Confini, Gris e Jurosa" presentati da Enobucolico
I vini Ronco del Gnemiz degustati da Enobucolico
Ronco del Gnemiz è indiscutibilmente una delle cantine più interessanti in Friuli come i suoi vini chardonnay, Sauvignon e Friulano.
Enobucolico: 11 vini rosati italiani da comprare nel 2021
Enobucolico presenta gli 11 vini rosati da comprare nel mese di ottobre 2021. Scopri i vini rosati come: Nerello Mascalese, Lagrein, Negroamaro e Gaglioppo.