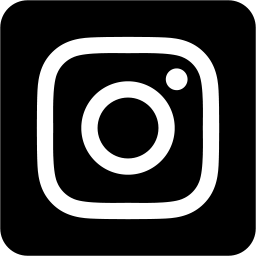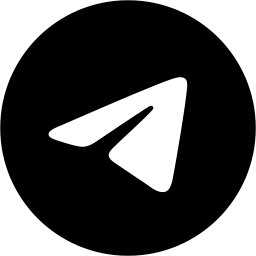Jacques Selosse, uno champagne di rottura.
Anselme Selosse, figlio di Jacques Selosse, è uno dei produttori di champagne più venerati del momento. La cantina è ad Avize nel cuore della Champagne ed i suoi vini sono tra i più ricercati dell'intera regione e raggiungono prezzi folli sul mercato secondario con un andamento distaccato dalle quotazioni degli champagne più commerciali. Gli amanti del vino viaggiano da ogni angolo del mondo per visitare Selosse e degustare nelle sue cantine. Da questo punto di vista, Selosse è straordinariamente generoso ed accogliente.
Selosse, tuttavia, non è sempre stato così popolare ed ha vissuto un'infanzia difficile, come egli stesso ricorda, soprattutto perché era un bambino in sovrappeso e soffriva anche di una fastidiosa malattia della pelle. Come si può immaginare, in una piccola città di campagna come Avize, Selosse si è trovato ad essere bullizzato da molti dei suoi coetanei. Questo rifiuto lo ha segnato profondamente e ha alimentato in lui una forte spinta a realizzare qualcosa di significativo, come molti grandi uomini. Gli ha dato qualcosa da dimostrare, il fatto di essere un outsider gli ha insegnato a giocare e lavorare da solo e, in seguito, a sentirsi a proprio agio nell'innovare senza dover cercare il consenso.
Altri due fattori sono stati fondamentali perché Selosse diventasse l'uomo che è oggi. In primo luogo, da quando ha memoria, è sempre stato ossessionato dal capire come funzionano le cose. Da adolescente, smontava continuamente le macchine e le ricostruiva in modi diversi per vedere se poteva migliorare gli originali. Questa è la chiave per comprendere il suo approccio alla viticoltura. Ha rotto con la biodinamica perché ha scoperto che c'era un elemento di "autosuggestione" nel pensiero di molti praticanti della biodinamica; cioè, molti elementi erano accettati come funzionanti senza una vera comprensione del come o del perché. In secondo luogo, Selosse aveva una madre molto severa. Questo è significativo, perché è stata la sua natura dominante, insieme al suo senso di distacco dai coetanei, a incoraggiarlo a lasciare Avize non appena ha avuto una scusa per farlo. A dodici anni andò in collegio e a quindici studiava a Beaune, nel cuore della Côte d'Or della Borgogna. La maggior parte dei figli dei viticoltori di Avize, se hanno studiato viticoltura, lo hanno fatto al Lycée Viticole di Avize. Lì sono stati indottrinati nelle metodologie di viticoltura e vinificazione "tradizionali", o convenzionali, che ancora oggi dominano in Champagne. Selosse ha studiato “fuori” e questo lo ha influenzato notevolmente.
Come ogni appassionato di vino sa, in Borgogna, la struttura della regione e le sue leggi AOC sono state concepite per valorizzare il terroir dei singoli vigneti e comuni, un approccio differente da quello di Champagne. Selosse ebbe la fortuna di seguire alcuni corsi sperimentali, tra cui uno sull’ecologia che approfondiva alcune tematiche fondamentali: ecosistemi, biotopi, interazione tra geologia, clima e vita vegetale e l'idea di osservare la natura per imparare da essa
Si narra che sia stato proprio questo corso a sviluppare la passione per l’enologia in Jacques Selosse. Egli aveva scoperto che c'era un quadro molto più ampio a disposizione quando si trattava di gestire i vigneti, che c'era molto che non era ancora stato compreso su come le viti interagiscono con il loro ambiente e che era molto probabile che molte pratiche convenzionali fossero costruite su false premesse.
Dopo aver terminato gli studi, Selosse si è recato nella regione della Rioja, in Spagna, per fare un'ulteriore esperienza. In Spagna ha sperimentato due tecniche di vinificazione che hanno fortemente influenzato il suo approccio quando è tornato in Champagne. La prima era l'invecchiamento "reserva", in cui i vini vengono tenuti per lunghi periodi in botte prima dell'imbottigliamento, cambiando così radicalmente la struttura e i profili aromatici e gustativi del vino. Il secondo è il sistema "solera", in cui molte annate vengono assemblate insieme per creare il vino finale.
Quando Selosse tornò a casa nel 1974, egli inizio a lavorare in campagna e mettere in pratica la sua visione sulla viticoltura e la produzione di champagne e molto presto, abbandonò l'uso di erbicidi. Selosse aveva capito che la relazione tra le viti e il loro terroir era profondamente complessa e che molte pratiche viticole comuni non erano basate sulla qualità o sulla conoscenza, ma sulla convenienza economica. Selosse iniziò a mettere in discussione tutto, facendosi domande e cercando nuove risposte, libere da preconcetti a partire dalla filtrazione in cantina. La filtrazione è una tecnologia moderna introdotta per facilitare la chiarificazione e consentire di portare in bottiglia più velocemente i vini base.
Selosse si rese conto che con la filtrazione si perdeva qualcosa: i vini trascorrevano meno tempo a contatto con le fecce, venivano privati del loro carattere naturale e spesso raccoglievano aromi e sapori sgradevoli dalla tecnologia di filtrazione dell'epoca. Era un passo audace in un'epoca in cui gli enologi consigliavano ai loro clienti che la filtrazione era necessaria per garantire vini stabili e puliti. Questa scelta ebbe un effetto positivo sugli imbottigliamenti dei suoi champagne e a sua volta, gli diede la fiducia necessaria per mettere in discussione altre pratiche convenzionali.

Come era facile immaginare, molti colleghi pensavano che fosse un pazzo, poi, quando i suoi vini cominciarono a riscuotere un certo successo, furono in molti a definirlo apertamente un ciarlatano o ad accusarlo di produrre vini che non erano "veri" Champagne. Le note di legno (affinamento in barrique di rovere) e di ossidazione (l’assemblaggio perpetuo, simile in parte al metodo solera) sono tra le caratteristiche più riconoscibili di Selosse e furono, all’inizio, le maggiori critiche mosse ai suoi vini.
Lo status di icona di Selosse nel mondo del vino l'ha visto essere citato come riferimento per molte ideologie, a partire dalla biodinamica oppure a posizioni di rottura che vedono lo Champagne in conflitto con l’establishment in essere. La più fuorviante di queste associazioni è stata quella con il cosiddetto vino naturale, un termine ideologico senza nessun riferimento concreto. Jacques Selosse riguardo il vino naturare ha detto "Questa idea non ha senso. Il vigneto non è naturale. Il vigneto è una monocultura. La natura è la foresta".
A questo punto, come dargli torto? Ciò che abbiamo appena visto confuta qualsiasi “naturalezza” che noi associamo al vino. Nel vigneto, una singola pianta domina come non potrebbe fare in un ambiente naturale, e questo crea uno squilibrio del tutto artificiale. La natura - la cui tendenza è quella di introdurre la biodiversità per competere e nutrirsi di qualsiasi squilibrio o abbondanza (in questo caso le viti e i loro frutti) - deve essere tenuta a bada, almeno in una certa misura, se si vuole produrre vino di qualità. Per molti versi, il lavoro del vigneron (anche quello che lavora a stretto contatto con la natura) è in diretta opposizione alle forze della natura. Scegliere se intervenire per aiutare il vigneto a resistere alle minacce che la natura inevitabilmente gli pone è una decisione cruciale.
I grandi viticoltori non si illudono di essere in armonia con la natura. Fanno del loro meglio per lavorarvi parallelamente, pur sapendo che ciò che fanno, di naturale, non ha nulla. “Naturale" significa "della natura" e indica letteralmente tutto ciò che non è soggetto all'influenza dell'uomo. Questa è la radice della parola. Per impiantare un vigneto è necessario dissodare il terreno e selezionare le viti: nel caso della Vitis vinifera, la vite europea che utilizziamo oggi, questo processo di selezione è avvenuto nel corso di migliaia di anni, allontanandole dai loro antenati selvatici. Queste viti devono poi essere propagate, (spesso) innestate e protette artificialmente dal marciume, dalla “concorrenza”, dagli insetti e dagli animali (anche se non vengono utilizzate sostanze chimiche di sintesi). E questo prima di arrivare alla vinificazione. No, il vigneto e i vini che ne derivano sono il prodotto di migliaia di anni di cultura, non di natura: una realtà che non dovremmo criticare, ma celebrare.
A proposito di cultura: alcuni vini di Selosse sono prodotti con una metodologia definita "assemblaggio perpetuo". L'ho sentita spesso descritta come solera, ma non sono sicuro che sia un termine del tutto accurato, poiché il processo di Selosse non prevede le varie "criaderas" (livelli di invecchiamento) del tipico sistema solera praticato in Spagna per la produzione di sherry. Piuttosto, Selosse miscela tutte le annate di ogni singolo terroir in un unico recipiente, rabboccandolo ogni anno con il nuovo raccolto prima di imbottigliare una parte della miscela come sua prossima uscita. Un sistema di questo tipo, credo, sia più precisamente descritto come un "blend perpetuo", o forse un "blend storico". Mi rendo conto di essere un po' pignolo, ma credo che la precisione sia importante per capire esattamente cosa Selosse stesse cercando.
In un sistema di solera, le varie criaderas ed il livello più vecchio non sono la stessa tenuta. In questo modo il produttore ha la possibilità di assemblare selettivamente vini di varie età per produrre uno stile coerente della casa o della solera. Alcune criaderas, o la solera stessa, e persino alcune botti, possono avere un ruolo maggiore o minore nell'assemblaggio. Possono anche essere escluse del tutto dall'assemblaggio, se interferiscono con lo stile di vino ricercato. Per Selosse, invece, tutto è mescolato. La sua idea è quella di utilizzare questo assemblaggio di più annate per ridurre al minimo l'impatto di una singola annata e presentare al bevitore una bottiglia di vino che rappresenti una visione più completa di ogni terroir - verruche e tutto il resto. Non saprei se convenire che queste bottiglie siano più complete oppure obiettare che siano bottiglie diverse, ma è comunque un ottimo spunto di riflessione sul concetto di terroir.

I vini dello Champagne Jacques Selosse.
Più spesso che no, i vini di Jacques Selosse sono ricchi, intensi, di straordinaria profondità e vinosità, molto materici e, colloquialmente, "vinosi". Ciò riflette il fatto che Anselme Selosse raccoglie solo frutta pienamente matura ed espressiva (molto più matura di quella che viene considerata tipicamente matura nella regione, e anche di quella che alcuni altri produttori di qualità considerano matura) e che poi affina i vini lentamente in botte, sulle loro fecce, con una solforosa minima. I vini non sono certo per tutti (come chiariscono le recensioni di alcuni critici enologici), e va bene così. Lo scrittore inglese Tom Stevenson è stato il critico più accanito, ma ho sentito anche altri professionisti del vino dichiarare che "non sono il mio stile". Naturalmente, molti altri amano questi vini, e io sono uno di questi, ma non dovete fidarvi di me: prendete qualche bottiglia e decidete per conto vostro. Assicuratevi di provarli in un bicchiere da vino decente, con del cibo e con amici disposti a dividere le spese.