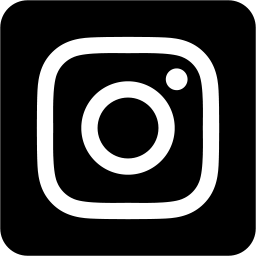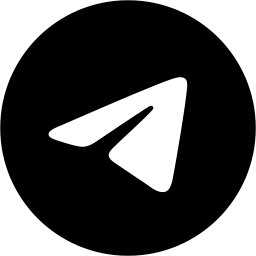Il Metodo Champenoise, il segreto dello Champagne
Il Metodo Champenoise è una tecnica di produzione di spumanti equivalente al Metodo Classico ma, quando si parla di Champagne, è più corretto fare riferimento al Metodo Champenoise. La produzione moderna di champagne non si discosta molto da quella che si faceva ai tempi Dom Pierre Pérignon. Questo metodo, noto come Metodo Champenoise, è utilizzato anche al di fuori della regione dello Champagne. In effetti, la maggior parte dei produttori italiani di vini spumanti utilizza questo metodo per creare i propri champagne (ad esclusione del famoso Prosecco Valdobbiadene che usa metodo differente, vedi differenza tra Metodo Classico e Metodo Martinotti).
Il Metodo Champenoise prevede le seguenti fasi, ben distinte nel tempo.
1 - La prima fermentazione alcolica
Di base lo champagne è un vino, un vino inizialmente fermo, prodotto come gli altri. In Champagne si coltivano principalmente tre tipi di uve: Chardonnay, Pinot Meunier e Pinot Nero, anche se le varietà ammesse nella produzione dello Champagne sono di più. Intorno alla metà di settembre (ma questo è un fattore variabile) le uve raccolte vengono pressate per ottenere un succo chiamato mosto d'uva. Dopo la pressatura, il mosto viene trasferito in grandi contenitori senza coperchio, chiamati tini, dove viene aggiunto del lievito, un tipo di fungo noto come Saccharomyces cerevisiae, e si lascia che questo inizi ad agire, facendo “ribollire i tini” e sprigionando un meraviglioso profumo nell’aria.
Questo primo passaggio è realmente l’inizio di tutto, una reazione chimica chiave nella vinificazione, conosciuta come fermentazione alcolica, che vede i lieviti convertire gli zuccheri in alcool e anidride carbonica come elemento secondario. La conoscenza del processo chimico della fermentazione risale al 1800, quando il chimico francese Joseph-Louis Gay-Lussac descrisse per la prima volta il processo di fermentazione in termini scientifici. Il modo in cui il lievito contribuisce al processo di fermentazione non è stato chiaramente compreso fino al 1857, quando il famoso microbiologo francese Louis Pasteur rese completa e definitiva la comprensione del processo. Cosa scoprì Pasteur? Che il glucosio (C6H12O6) presente nel mosto viene divorato dal lievito che produce etanolo (CH3CH2OH) e anidride carbonica (CO2). Una cosa curiosa in questo contesto è il fatto che
la quantità di alcol generata da questa prima fermentazione è di circa l'11%. Questa percentuale è la quantità massima di alcool prodotta prima che tutte le cellule di lievito vengano uccise dalla sua concentrazione. Dopo la prima fermentazione, lo Champagne è un vino bianco fermo e tutta l’anidride carbonica prodotta durante la fermentazione nei tini è stata rilasciata nell’aria.
2 - L'arte dell'assemblaggio
Poiché è raro che un singolo vino di un'unica annata, proveniente da un unico vigneto e da un'unica varietà d'uva, possa fornire il perfetto equilibrio di sapore, livello zuccherino e acidità, è solito per uno champagne mescolare diversi vini fermi. Questa fase è chiamata assemblaggio (o taglio oppure ancora cuvée) e viene effettuata direttamente dopo il completamento della prima fermentazione, utilizzando vini base fermi.
L'assemblaggio è considerato un punto fermo nella produzione di Champagne anche se esistono eccezioni eccellenti da Salon a Krug. Lo Chef de Cave può assemblare anche centinaia di vini diversi, provenienti da diverse varietà d'uva, vigneti e annate. Lo Champagne, per rispettare lo stile della Maison, è costruito vino su vino fino al raggiungimento del perfetto risultato. Questo assemblaggio richiede un notevole intuito perché è estremamente difficile prevedere il risultato finale di assemblaggi che verranno consumati a distanza di anni. L'assemblaggio dei vini fermi produrrà una miscela di vini che sarà imbottigliato per la seconda fermentazione, ed è questa la parte più interessante nella produzione dello Champagne.
3 - La Presa di Spuma o seconda fermentazione
Una volta creata la miscela base (o singolo vino in alcuni casi), si aggiungono zucchero (circa 24 grammi per litro), lievito e sostanze nutritive per il lievito. Questa nuova miscela viene messa in una bottiglia di vetro a pareti spesse e sigillata con un tappo a corona. Le bottiglie vengono poi poste in una cantina fresca (da 12 a 14° C) e il vino viene lasciato fermentare lentamente per una seconda volta, producendo nuovamente alcol e anidride carbonica all’interno della bottiglia. In questo caso, grazie al tappo a corona, l’anidride carbonica rimarrà intrappolata nel liquido producendo le famose bollicine o quasi. L'anidride carbonica non è ancora sotto forma di bollicine, ma piuttosto sotto forma di molecole di anidride carbonica disciolte nel vino. Quei 24 grammi di zucchero per litro di vino produrranno circa 12 grammi di anidride carbonica e un aumento dell'alcool di circa 1,5%. Una volta terminata la fase della Presa di Spuma, la pressione sotto il tappo sarà di circa 6 atmosfere e questo valore è una discriminante degli spumanti metodo Champenoise.

4 - Affinamento
Con il procedere della seconda fermentazione, le cellule di lievito esauriscono la propria capacità di trasformare glucosio in alcool ed anidride carbonica; dopo alcuni mesi, quando tutte le cellule di lievito saranno esauste e la fermentazione può definirsi completa. Sotto il tappo, la pressione gassosa ha raggiunto le 6 atmosfere, ma lo champagne continuerà ad affinare in cantina per almeno nove mesi e talvolta per diversi anni, come per i più prestigiosi Champagne tipo Dom Perignon. Questo processo di invecchiamento consente lo sviluppo del cosiddetto bouquet dello champagne. Durante questo periodo, le cellule di lievito si aprono e le loro sostanze si riversano nella soluzione in un processo chiamato autolisi del lievito, conferendo allo champagne sapori complessi e sentori di lievito stessi. Il sapore "tostato", molto ricercato, deriva da un'ulteriore scomposizione chimica delle cellule di lievito esauste. Più a lungo lo champagne invecchia, più questo sapore diventa ricco e più lo champagne viene apprezzato, alcuni di questi possono affinare in bottiglia anche 15 o 20 anni, come Dom Perignon P2 o P3.
5 - Remuage e Sboccatura
Una volta completato l'invecchiamento, al produttore di champagne rimane un problema: come espellere il lievito esausto dalla bottiglia senza perdere le bollicine. La procedura completa per farlo è una serie di due fasi, il Remuage e successivamente Sboccatura.
Questa procedura è fondamentale per rendere lo Champagne limpido e brillante (il lievito, infatti, lo rende torbido) oltre a permettere di ottenere un gusto più gradevole. Questo potrebbe essere un motivo sufficiente per eseguire la Sboccatura, ma c'è anche una questione di gusto.
Il processo di Remuage consiste nel collocare le bottiglie in apposite rastrelliere che mantengono il collo inclinato verso il basso. Questa inclinazione costringe le cellule di lievito morte a entrare nel collo della bottiglia per via della forza di gravità che le spinge verso il basso. Due volte al giorno, le bottiglie vengono leggermente rotate di un quarto di giro, il processo è tipicamente gestito da macchine automatiche.
Le bottiglie vengono poi sottoposte a un processo di Sboccatura, ovvero i colli delle bottiglie vengono congelati, creando un piccolo tappo di ghiaccio nella parte superiore della bottiglia che trattiene i sedimenti delle cellule di lievito esauste. I tappi delle bottiglie vengono rimossi e la pressione che si sprigiona spinge il ghiaccio, insieme a tutti i sedimenti di lievito, fuori dalla bottiglia. Durante la Sboccatura, si perde parte del vino che deve essere sostituito con un liquido e questo ci porta all'ultima fase, probabilmente la più segreta, della produzione dello champagne: il dosaggio.
6 - Dosaggio
Il dosaggio consiste nell'aggiungere alla bottiglia una piccola quantità di "liquido" (una miscela di zucchero e vini vecchi) per sostituire la parte di vino persa durante la Sboccatura. Ogni casa di champagne ha una formula segreta e ben custodita per questo “liqueur d'expedition”.
L'ampia variazione dei livelli di dolcezza di uno champagne - da brut (molto secco) a doux (molto dolce) - dipende dalla quantità di zucchero aggiunta durante la fase di dosaggio. Le bottiglie vengono poi rapidamente tappate con i tradizionali tappi e gabbie in metallo, ricevono le etichette e sono quindi pronte per raggiungere le enoteche e successivamente allietare i nostri momenti.